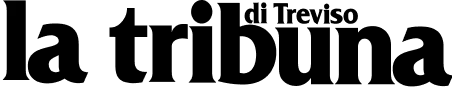Viaggiando verso Jesolo: io e le auto di papà
Il racconto di Roberto Ferrucci. Per ragioni di lavoro ne cambiava una all’anno e ogni nuovo modello ha scandito per noi in famiglia il tempo della vacanza e del diventare grandi

La prima che ricordo è la Fiat 1100 color caffellatte. Non le fanno più di quel colore le macchine, adesso. Prima ancora, ma non ho ricordi precisi, c’erano state la Fiat Multipla variopinta coi colori dell’azienda – la Bongas – verde giallo nero e bianco, credo. Restano solo due foto in bianco nero, dove ci sono io, un anno o poco più, insieme a Livio, mio padre, fuori della Multipla, nell’altra in braccio a Edda, mia madre, al posto di guida. Poi c’erano state la 750 bianca, la 850, di nuovo color caffellatte.
Non erano solo le auto del boom economico, le Fiat, erano anche le auto che l’azienda forniva a mio padre, per il suo lavoro da più di centomila chilometri l’anno. Ogni anno un’auto nuova.
Una pacchia per me bambino che, sul finire degli anni Sessanta, avevo imparato a riconoscere i modelli dal suono dei motori. Poi, su decisione di mio papà che per via di tutti quei chilometri aveva bisogno di vetture più potenti, si chiuse l’epoca Fiat, con il benestare entusiasta dei suoi due figli. Mamma, imparziale. L’azienda gli forniva la cifra equivalente a una 127, il resto usciva dal portafogli di casa.
Arrivò così una Simca 1301 bianca che paragonata alla 850, a me sembrava una Rolls Royce. Poi arrivò la prima Giulia 1300, ancora – non ne potevo più – color caffellatte.
Le auto di mio padre diventavano ben più importanti
Le auto di mio padre diventavano però ben più importanti, assumevano un valore ulteriore e magico ai miei occhi di bambino, quando si partiva in viaggio per la villeggiatura. Viaggio: Mestre-Jesolo, quarantacinque chilometri in tutto. Ma mio fratello Mauro e io non ci dormivamo la notte, quel breve tragitto portava con sé il mistero della vacanza, e quel mistero incominciava la mattina presto, quando si caricavano i bagagli in macchina. Erano gli anni d’oro delle ferie, un mese al mare, un mese in montagna.
Potrei descrivere la disposizione di valigie e scatoloni in base ai diversi bagagliai di ogni macchina. Oppure fare la lista dei differenti modelli di portapacchi, quelli da montare sul tetto della macchina. Ciascuno con le sue cinghie elastiche per bloccare le valigie: dovevi fargli fare due, tre giri per tenderle al massimo e guai a farsele sfuggire di mano durante l’operazione.
Non se ne vedono più in giro, di portapacchi. Del resto, oggi, chi se li può permettere due mesi di villeggiatura che negli anni Sessanta-Settanta erano alla portata anche della famiglia di un impiegato? Dopo qualche decina di chilometri la frontiera con la vacanza era lì Dopo qualche decina di chilometri, ogni anno, la frontiera con la vacanza era lì, più o meno a metà del viaggio, al primo dei nomi che scandivano la lenta marcia di avvicinamento verso la destinazione: Ca’ Redenta, Ca’ Speranza, Ca’ Favorita, Ca’ Fertile, Ca’ Feconda, Ca’ Florida. Dal finestrino, quelle antiche case coloniche erano il conto alla rovescia di noi ragazzini ansiosi di mare.
Mio fratello e io facevamo a gara ad anticiparne i nomi a memoria. Una sorta di litania da recitarsi nell’attesa, evocativa, piena di chissà quante e quali storie. Mio papà, stava a Jesolo solo due settimane. Per qualche anno ogni pomeriggio ha aspettato insieme a noi il passaggio dell’aereo con lo striscione pubblicitario appeso dietro, che lanciava a caso in mare dei pacchetti impermeabili.
Le volte che il lancio arrivava più o meno all’altezza del nostro settore, mio fratello e io, ancora troppo piccoli, facevamo scattare papà, che si tuffava in acqua come Mark Spitz (aveva pure i baffi come lui, all’epoca) e la sua missione era di recuperarne ogni volta almeno due di quei pacchetti, che poi erano quasi sempre delle scemenze che però papà – nostro eroe – riportava puntualmente a riva, gareggiando e rivaleggiando con altri padri vicini d’ombrellone, salvo quella volta che l’omaggio era un aeroplanino di plastica da montare, di quelli da tirare con l’elastico, e ne riportò solo uno a riva e mia madre dovette dividerci, a mio fratello e me, quando mettemmo quattro mani prima attorno al pacchetto che lo conteneva, poi attorno al collo l’uno dell’altro. Fino alla Giulia 1300 color caffellatte, la meta della vacanza era un albergo che stava in via Bafile, a metà tra Piazza Aurora e Piazza Mazzini.
L’Hotel Patrizia. Scaricare i bagagli era uno spasso. L’andar su e giù fra la macchina e l’ascensore serviva già ad adeguare l’occhio alla nuova residenza estiva. Perché anche se è stata la stessa per anni e anni, ogni volta c’era qualche piccola variazione: il bancone del bar, la disposizione dei tavoli in sala ristorante, le tende o le poltrone. E poi i clienti.
C’erano gli habitués, quelli in cui notavi i mutamenti del viso, i figli che crescevano, e io che cercavo di spiegarmi perché loro mettessero su sempre più centimetri di me: che tipo di trucchi usavano i maledetti? E ricordo bene l’anno – quello dell’Alfetta 2000 color carta da zucchero – in cui mi resi conto che anche le mie coetanee crescevano.
Dalla Giulia 1300 color indaco la destinazione cambiò
Dalla macchina successiva, la Giulia 1300 color indaco, la destinazione delle vacanze cambiò. Passammo a un appartamento, sempre nella stessa zona. Io e mio fratello eravamo più grandi, ci volevano due stanze e l’appartamento era più conveniente.
Il viaggio era diventato un trasloco. Dev’essere per questo motivo che ricordo bene la targa della Giulia color indaco, VE 225202, per via di tutti gli avanti e indietro necessari a comporre il mosaico di valigie, pacchi, televisione portatile, pentole. E ricordo ancor meglio la targa di una delle successive: VE 292287, con la targa nuova, orizzontale, il VE arancione e i numeri in bianco. Bellissima la macchina nuova, una Renault 177 TL arancione. Ma, in quanto a capienza, accidenti alla moda delle coupé.
Come la macchina dell’anno dopo, meno aggressiva, ma pur sempre coupé, la Renault 15 e non ricordo la sigla, color carta da zucchero pure quella (caffellatte, zucchero: che ci fosse un messaggio da parte di papà?). Il momento topico, per le due Renault, è stata l’uscita dal cancello del cortile di via Vallon 10. Mio padre attraversava quel confine come se si trattasse di un campo minato: la coppa dell’olio rischiava di sfracellarsi contro il perno centrale del cancello, quello piantato nell’asfalto.
Ci provava sempre, papà, anche in retromarcia, poi, puntualmente, mia mamma era costretta – noi due figli incastrati dietro – a scendere, portando al di là della frontiera condominiale sé stessa e due o tre borse, le più pesanti, e si riusciva a partire.
A distanza di decenni mi rendo conto
A distanza di decenni, e raccontando queste storie, mi rendo conto che le macchine di mio papà hanno scandito i momenti della mia vita, evocatrici di epoche e di storie (la 177TL sarà per sempre la macchina “con” Stefania, il primo amore della mia adolescenza, anche se credo non ci sia mai salita). Elementi dell’immaginario, più che mezzi di trasporto.
Dev’essere per questo che ho incominciato a scrivere presto – fra le due Giulia, direi, a occhio – e che, invece, non ho mai preso la patente.
L’autore: Roberto Ferrucci

Roberto Ferrucci è nato a Venezia (Marghera) nel 1960. Il suo primo romanzo, “Terra rossa” (Transeuropa) è uscito nel 1993, il più recente, “Storie che accadono” (People), nel 2022. Il prossimo, “Il mondo che ha fatto”, sarà pubblicato da La Nave di Teseo nel 2025. Molti suoi libri sono stati tradotti in francese, altri testi in spagnolo, tedesco, inglese.
Dal 2002 insegna Scrittura creativa all’Università di Padova, per la Scuola Holden e in Francia. Per l’Editrice Helvetia dirige la collana Taccuini d’Autore.
Dal 1978 scrive per i nostri giornali. Collabora al Corriere della Sera e a Le Monde. Il titolo, “Viaggiando verso Jesolo”, è un omaggio al cantautore mestrino Lucio Quarantotto.
Riproduzione riservata © Tribuna di Treviso