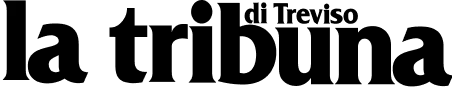La mappa di affetti che sta tra le Rose e Mario il cercatore
Il racconto firmato da Luigi Nacci: “Era sufficiente fare il loro nome e da un capo all’altro del mondo ci si riconosceva. Il figlio era un saggio e sapeva cogliere la verità che si sprigiona dalle osterie”

LE ROSE Il primo giorno dell’anno era sacro per la famiglia: si andava tutti a festeggiare a case delle zie vedove di guerra. L’appartamento era di
Articolo Premium
Questo articolo è riservato agli abbonati.
Accedi con username e password se hai già un abbonamento.
Scopri tutte le offerte di abbonamento sul nostro shop.Shop
Non hai un account? Registrati ora.
Riproduzione riservata © Tribuna di Treviso
Leggi anche