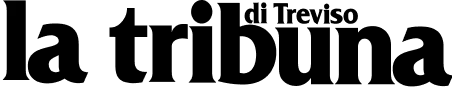Il destino di Gilda che temeva i fucili, gli spari e i tuoni
Il racconto di Dario Cresto-Dina. Nel cortile c’era una pietra bianca, larga e piatta: pesava più di venti chili. Sembrava attendere qualcosa, ma arrivò la ragazza. La pietra tornò nel fienile

Venne il cantante. Non la degnò di uno sguardo. Le monete in una tasca dei pantaloni e l’armonica nell’altra. Sul metallo l’odore della sua saliva. Si esibiva la domenica pomeriggio nei balli a palchetto montati nel prato sotto la chiesa prima che toccasse all’orchestra del liscio. Sapeva tre canzoni. La prima era uguale alla terza e la terza assomigliava alla seconda. Accettò una sedia di plastica e un goccio di vino.
Prima di salire in vespa le buttò un occhio. Gettatela nel pollaio, disse. Non mi piacciono le femmine con i baffi. Qualche settimana dopo impazzì e scaraventò dal quarto piano tutti i mobili di casa.
I carabinieri lo lasciarono fare tenendo la piccola folla dietro i nastri biancorossi. I militari chiacchieravano tra loro, si accendevano una sigaretta asciugandosi ogni dieci minuti con il fazzoletto di stoffa il sudore che da sotto la visiera del cappello colava sulla fronte e sulle guance. Il cantante scese le scale da solo e si consegnò buono buono. Poi salì nell’ambulanza.
Un infermiere raccontò che piangeva a dirotto. Un altro disse che non era vero. Ma che tirò fuori il portafoglio e mormorò: voglio soltanto vedere se posso permettermi di avere sete. Da allora lo chiamarono Ringo. Una domenica prese un treno per Milano e si perse per sempre.
La cascina stava su una collina sopra le vigne del prosecco
La cascina stava su una collina sopra le vigne del prosecco. Lei lo aveva sposato perché era un uomo pratico. Piantò alberi da frutta e comprò tre cavalli. All’inizio della strada sterrata, polvere e erba bruciata dal sole, mise un palo e un cartello con su scritto Agriturismo Il Gobbo. Sotto in lettere più piccole “Conduzione famigliare”.
È un nome inquietante, gli aveva fatto notare. Lui la ignorò e le disse: vedi, ti ho appena trovato un lavoro. Poi la portò nel letto. Avevano sempre scopato come un dovere.
Quella volta le parve di avvertire qualcosa in più, un tremore di lui durante l’orgasmo. Dopo, per molto tempo non la toccò più. Era un cacciatore, gli interessavano solamente fucili e bestie. Venivano dai paesi vicini per trattare con lui cani ed armi, ma anche soltanto per sentirlo parlare. Quello è uno che sa, dicevano. Senza pensarci su. La pietra stava nel cortile, larga e piatta e bianca.
Era stata presa nelle acque dell’Orco e pesava più di venti chili. Non era facile alzarla sopra la testa. Venne il Giò. Lo chiamavano così perché forse era stato con gli americani. C’era una foto di lui giovanissimo con l’uniforme dell’Us Navy. Era l’uomo più bello del paese con quegli occhi azzurri sotto i capelli bianchi, ma aveva la maledetta malattia del vino.
I tedeschi, spiegava. Colpa dei tedeschi. Mi hanno torturato nei campi di prigionia e qualcosa si è rotto nella testa. Si tuffava in notti che trasformava in delirio. Gridava davanti ai portoni e ai cancelli in una lingua sconosciuta.
Rimediava pugni in faccia e nasi rotti, rovinose cadute dal motorino, furti della pensione. Se non finiva svenuto in un fosso dopo tre giorni tornava a nascondersi in casa. La vergogna gli toglieva la voce, non l’eleganza della camicia bianca che portava a messa come nelle sveglie all’alba per andare per funghi. Dopo l’8 settembre salì in montagna con i partigiani, quelle montagne che appartenevano alla sua famiglia. Di cui era rimasto solo lui. Vide la pietra, l’uomo gli indicò il pollaio con un gesto stanco della mano.
Rimase alcuni secondi a riflettere in silenzio, poi disse: aspettate, porto su mia nipote e vediamo che succede. Quando se ne andò pensarono che o mentiva o il Giò non era davvero l’ultimo di una sventurata dinastia.
Dissero, non dobbiamo fidarci Avrà già scordato la promessa
Dissero, non dobbiamo fidarci. Avrà già scordato la promessa quell’ubriacone. Invece no. Tornò due pomeriggi dopo e non era solo.
Con lui c’era una ragazza che non dimostrava ancora diciott’anni. Magra, capelli scuri, gli stessi occhi del Giò. Questa è Marta, disse. Scesero al pollaio calpestando un sentiero arido e duro. Una rete era appoggiata a quella della recinzione esterna. Creava un misero spazio isolato dove una dozzina di galline si abbandonavano consumate dal caldo dentro le buche da loro stesse scavate. Non avevano più penne sul collo, sembravano piccoli avvoltoi appena morti. E poi c’era lei. Rossa di pelo, sotto il mento i baffi e un accenno di barba caprina, la coda ridotta a un moncone. Giurarono di averla sentita parlare nella stessa lingua misteriosa del Giò. La ragazza invece sembrava comprenderla. Vieni con me, disse alla cagna. E avrai un nome importante, Gilda. Nessuno domandò altro.
Gilda ostentò diffidenza, poi trotterellò a fianco di Marta. Non si tengono i cani che hanno paura del fucile. Sono solo bocche da sfamare. Inutili per la caccia, devono essere eliminati. La pietra che avrebbe dovuta ucciderla venne riportata nel fienile.
Il Giò se n’è andato nel sonno dentro una camicia bianca. Gilda è ancora terrorizzata dagli spari, dai petardi e dai tuoni. Quando succede si ripara nella doccia. Resta seduta, immobile e dritta come una sentinella nella sua garitta.
L’autore: Dario Cresto-Dina
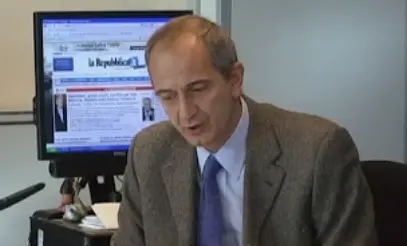
Dario Cresto-Dina, torinese di origine, è stato vicedirettore della Stampa e di Repubblica. Ha scritto “Sei chiodi storti” sulla vittoria italiana della Coppa Davis in Cile nel 1976, affidando alla letteratura il resoconto di una cronaca che la storia aveva penalizzato. Il libro è edito da 66thand2nd.
Riproduzione riservata © Tribuna di Treviso